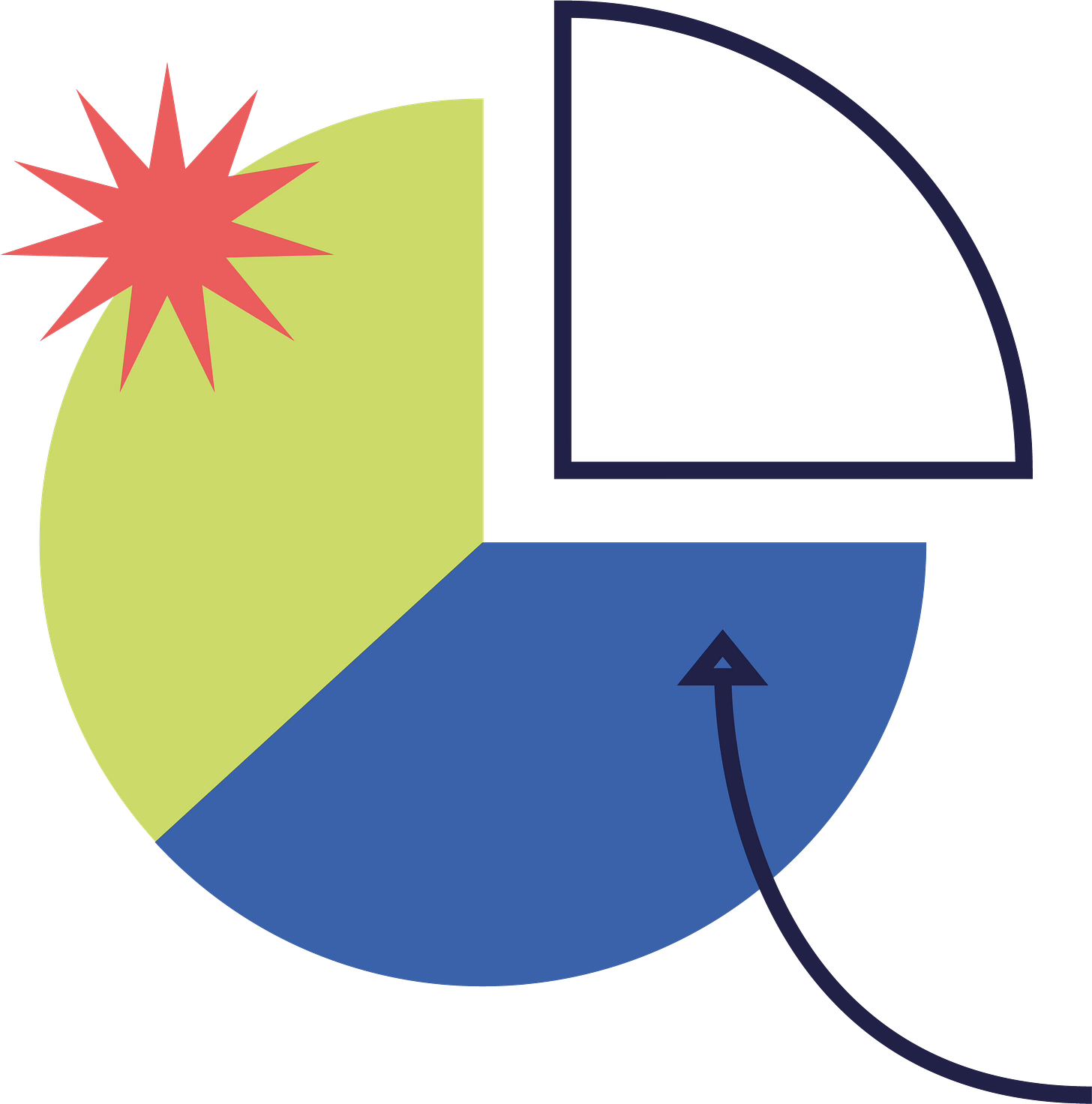L'assenza di dati è un dato, anche in ospedale
Storie di violenze ostetriche, ospedaliere e gender data gap sanitari
In questo numero: il pezzo di Alessandra Vescio sulla difficoltà di produrre e analizzare i dati sulla violenza ostetrica arriva nella settimana giusta. Perché solo pochi giorni fa l’attivista transfemminista queer Lunny, in una diretta Instagram molto coraggiosa, ha condiviso la sua esperienza di violenza ospedaliera subita in quanto donna autistica, ricoverata in un momento di crisi, dopo aver cercato invano dei dati che confermassero che quanto accaduto a lei non fosse una situazione isolata. E negli stessi giorni Paola Chiara Masuzzo ha scritto della mancanza di dati sulle fluttuazioni ormonali nelle pazienti curate con chemioterapia per carcinoma mammario, una situazione che la riguarda molto da vicino. Alla domanda “le mestruazioni torneranno”, i medici non hanno saputo rispondere perché non ci sono abbastanza studi in merito.
E oggi sono a Napoli in una formazione per giornalisti e giornaliste a parlare di dati sulla violenza di genere, che hanno diversi problemi in Italia.
Alessandra Vescio ci racconta che, almeno sulla violenza ostetrica, in altri paesi la situazione è diversa.
A differenza di quello che è successo nel Regno Unito, con una raccolta di dati ufficiale e nazionale, in Italia indagare e parlare di violenza ostetrica è ancora molto difficile.
Correte a leggere.
Dove ci vediamo in giro:
2 aprile, a Milano: talk all’università Bicocca.
7 aprile, online: si incontra il Data Book Club - La newsletter per parlare di Oltre Marie, libro di Edwige Pezzulli (Le Plurali ed. 2023).
10 aprile, a Venezia: con la comunità di Rame, parliamo di soldi e dati.
12 aprile, a Rovereto: al festival Educa Immagine con Giada Arena, Daniela Collu e Davide Piacenza, discutiamo di “TUTTI CONTRO TUTTI: perché l’algoritmo ci vuole arrabbiati”.
17 aprile, online: dialogo con Simone Ferrari, presidente del MENSA Italia.
3-4 maggio, a Foligno: intervengo al convegno del Gruppo di Terapia Manuale dove il tema è “Umanizzare i dati evolve la fisioterapia muscoloscheletrica”. Iscrizioni aperte.
🗞️ [angolo SkyTg24] Menopausa, coppetta mestruale, vulva, endometriosi, tumore al seno, aborto, ma anche piacere, sesso, intimità. Un elenco di parole che non dovrebbero più spaventarci nel 2025, ma che invece sono oggetto di frequente censura dentro le piattaforme social che frequentiamo quotidianamente. È la denuncia di sei startup del settore della salute femminile, che hanno deciso di sfidare questi atti di censura digitale presentando un reclamo formale alla Commissione Europea, guidate dalla campagna CensHERship e dal fondo di investimento The Case for Her. Per studiare la portata del fenomeno il Center for Intimacy Justice ha coinvolto più di 159 organizzazioni, content creator e aziende del settore attive in più di 180 paesi del mondo raccogliendo dati, ne ha parlato anche Alice Orrù - in modo critico - nella sua ultima newsletter. Io ho intervistato Norma Rossetti di MySecretCase per capire quale riscontro avesse ritrovato con la sua community da quasi 2 milioni di follower.
Sei tra le 10926 persone che leggono la newsletter. Nell’ultima puntata abbiamo parlato di decolonizzare la data visualization e la storia dei dati.
Intanto ti ricordo che se vuoi coinvolgermi in un evento puoi scrivere a contact-columbro@elastica.eu.
Per promuovere il prodotto della tua azienda, un evento o un corso in questi spazi scrivi a newsletter@tispiegoildato.it, rispondo io oppure Roberta.
Nella sezione a pagamento: i rifiuti a Gaza, un tutorial per fare dataviz come Du Bois, protocolli psicologici inutilizzati.
Bisogna educare i ricercatori e i medici, insegnare la scienza e la medicina in modo nuovo, completo e inclusivo, affinché gli errori del passato non si ripetano più.
Antonella Viola, Il sesso è (quasi) tutto: Evoluzione, diversità e medicina di genere (Feltrinelli 2022)
Perché è difficile parlare di violenza ostetrica? - di Alessandra Vescio
A maggio 2024, nel Regno Unito è stata pubblicata la prima inchiesta nazionale sui traumi da parto, un’espressione che in Italia coincide più o meno con quella di violenza ostetrica e in cui rientrano tutti quegli eventi legati al parto che hanno provocato conseguenze negative a breve e a lungo termine sul benessere psicofisico delle donne. Il report britannico è il frutto di oltre 1300 segnalazioni inviate per iscritto da chi aveva subito traumi da parto; 92 contributi di organizzazioni, enti professionali e membri del personale sanitario; e sette sessioni in cui genitori e professionisti hanno condiviso le loro esperienze.
Imposizione di pratiche senza consenso, carenza di ascolto e comunicazione, assistenza inadeguata, pressione ad allattare e negligenze mediche: questi sono alcuni dei temi emersi dal report, con le conseguenze più eclatanti che includono parti prematuri, nati morti, neonati con paralisi cerebrali e traumi fisici per le donne che hanno condizionato per sempre la loro vita.
“In molti casi”, si legge nel report, “il trauma è stato causato da errori e inadempienze commesse prima e durante il parto”, che sono stati poi “frequentemente […] insabbiati dagli ospedali”.
La situazione in Italia
A differenza di quello che è successo nel Regno Unito, con una raccolta di dati ufficiale e nazionale, in Italia indagare e parlare di violenza ostetrica è ancora molto difficile. Ad oggi non esistono dati ufficiali, ma solo ricerche di varia natura, che vanno da un’analisi dei fattori di rischio e conseguenze sulla salute mentale condotta su un gruppo ristretto di donne a uno studio sulla qualità dell’assistenza materna e neonatale durante la pandemia, fino a un progetto di ricerca condotto nel 2024.
Un’indagine che ha suscitato però molto dibattito è quella pubblicata nel 2017, condotta dall’Istituto per le ricerche statistiche e l’analisi dell’opinione pubblica Doxa per l’Osservatorio sulla Violenza Ostetrica in Italia (OVOItalia). Presentata come ricerca nazionale, questa indagine è il frutto di 424 interviste online a donne con figli tra 0 e 14 anni, di provenienza regionale, età e percorsi di studi e professionali differenti. Da questa indagine emerge che il 41% delle donne intervistate ha dichiarato di “aver subito pratiche lesive della propria dignità o integrità psicofisica”, il 33% di non essersi sentita “adeguatamente assistita”, il 21% di aver subito “una qualche forma di violenza ostetrica fisica o verbale alla loro prima esperienza di maternità”, il 6% di aver scelto di non avere altri figli in seguito a un trauma da parto. Da qui OVOItalia propone delle stime: sulla base dei dati ottenuti, circa 1 milione di madri avrebbe subito una qualche forma di violenza ostetrica e 20mila sarebbero i bambini non nati ogni anno a causa degli abusi subiti dalle madri durante il primo parto.
Alcune associazioni mediche hanno accolto malamente questa indagine, contestandone praticamente ogni aspetto. In una lettera di diffida diffusa pubblicamente, l’Associazione degli Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani AOGOI ha detto ad esempio che l’inchiesta conterrebbe
“gravissime espressioni offensive che evocano deplorevoli comportamenti ascrivibili al profilo professionale ostetrico (ostetriche, medici e personale sanitario), mai tenuti e mai provati”, con “un risultato gravemente diffamatorio e lesivo della reputazione dei professionisti”.
AOGOI ha poi criticato la metodologia dell’inchiesta, sostenendo che il campione di riferimento non possa considerarsi rappresentativo della situazione italiana e che siano state fatte domande tendenziose.
Un anno dopo la stessa AOGOI, insieme alla Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia SIGO e all’Associazione Ginecologi Universitari Italiani AGUI, ha pubblicato un’indagine sulla “soddisfazione delle donne in sala parto”. Definita anche questa come “nazionale”, l’indagine delle associazioni di settore è stata condotta tra marzo e agosto 2018 su 11590 partecipanti al momento delle dimissioni dall’ospedale e ha analizzato alcuni temi specifici e discussi anche nella ricerca Doxa, tra cui le informazioni ricevute prima del parto, l’assistenza durante il ricovero e la soddisfazione in reparto. Da qui emergono livelli di soddisfazione ed esperienze molto diverse da quanto riportato dall’inchiesta sulla violenza ostetrica: solo il 3,5% delle donne ad esempio si sarebbe detta insoddisfatta del sostegno ricevuto dall’ostetrica durante il parto e il 4,1% da quello ricevuto dal ginecologo, e complessivamente solo il 2,9% ha giudicato negativamente la qualità dei servizi ricevuti in reparto.
Chi ha ragione sulla violenza ostetrica
Guardando alle due indagini e ai risultati prodotti, sembra che queste si contraddicano l’una con l’altra. La raccolta dati condotta dalle associazioni di professionisti sanitari in particolare è stata descritta come la smentita di ciò che era stato detto nell’indagine sulla violenza ostetrica e la dimostrazione dunque che in Italia sarebbe scorretto parlare dell’esistenza di questo fenomeno. Anche l’utilizzo dell’espressione “violenza ostetrica” è stata molto criticata da AOGOI, che nella sua lettera di diffida l’ha definita
“uno strumento di offesa della reputazione dei professionisti sanitari”.
In realtà, l’espressione “violenza ostetrica” esiste da tempo e in alcuni paesi, come il Venezuela, l’Argentina e il Messico, è stata riconosciuta anche a livello istituzionale. Di violenza ostetrica poi ne ha parlato sia il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite sia la Commissione sull’uguaglianza e la non discriminazione dell’Unione europea con due report dedicati al tema. L’Organizzazione Mondiale della Sanità non utilizza l’espressione “violenza ostetrica”, ma parla comunque del rischio di maltrattamenti e abusi subiti dalle donne in sala parto.
Raccogliere dati sulla violenza ostetrica però è complesso. Innanzitutto, non esiste una definizione unanime di questo fenomeno, e in alcuni contesti questa espressione è usata per riferirsi esclusivamente agli abusi durante il parto, mentre in altri si include anche ciò che succede prima e dopo e che riguarda la salute riproduttiva e sessuale nel suo complesso. Inoltre, la normalizzazione di certe pratiche e la scarsa consapevolezza sul tema limitano la raccolta delle informazioni. Ma un ostacolo importante è anche quello che si incontra ogni volta che si parla di violenza di genere: un problema sistemico che non viene creduto.
Come spiega un’analisi condotta in Unione Europea, la violenza ostetrica si pone infatti all’intersezione di due fenomeni strutturali: la violenza di genere e la crisi dei sistemi sanitari.
La “lunga tradizione di controllo istituzionale, sociale e medico sul corpo delle donne” si intreccia ai finanziamenti inadeguati dei sistema sanitari, alla carenza di professionisti, alle condizioni lavorative stressanti: non è un caso allora che durante la pandemia la qualità dell’assistenza per le partorienti sia peggiorata. Non si tratterebbe allora di azioni “necessariamente intenzionali”, quanto del “prodotto di questioni strutturali”.
In alcuni contesti sono anzi gli stessi professionisti sanitari a chiedere di più: più conoscenza, più formazione, più supporto. L’associazione professionale Royal College of Obstetricians and Gynaecologists ad esempio ha risposto al report britannico sui traumi da parto riconoscendo la necessità di fare di più e meglio per le donne nel periodo perinatale e l’urgenza di assumere e formare più professionisti. In Francia, Austria e Polonia, le ostetriche hanno denunciato il rapporto impari tra donne e professionisti sanitari. In Italia molti medici hanno manifestato il desiderio di ricevere una migliore formazione sulla procedura di richiesta di consenso.
Per indagare e discutere di violenza ostetrica dobbiamo allora partire da qui: riconoscere l’esistenza del problema, comprenderne i tratti sistemici e credere alle voci di chi l’ha subita.
Alessandra Vescio è una giornalista freelance certificata in UK. Si occupa di questioni di genere, salute e diritti. Ha scritto per Al Jazeera, openDemocracy, The Fix Media e collabora con Valigia Blu e Marie Claire. È anche l'autrice di "La salute è un diritto di genere", un saggio sulle disparità in ambito medico e sanitario uscito nel 2023 per People. I data-link della settimana
a cura di Roberta Cavaglià