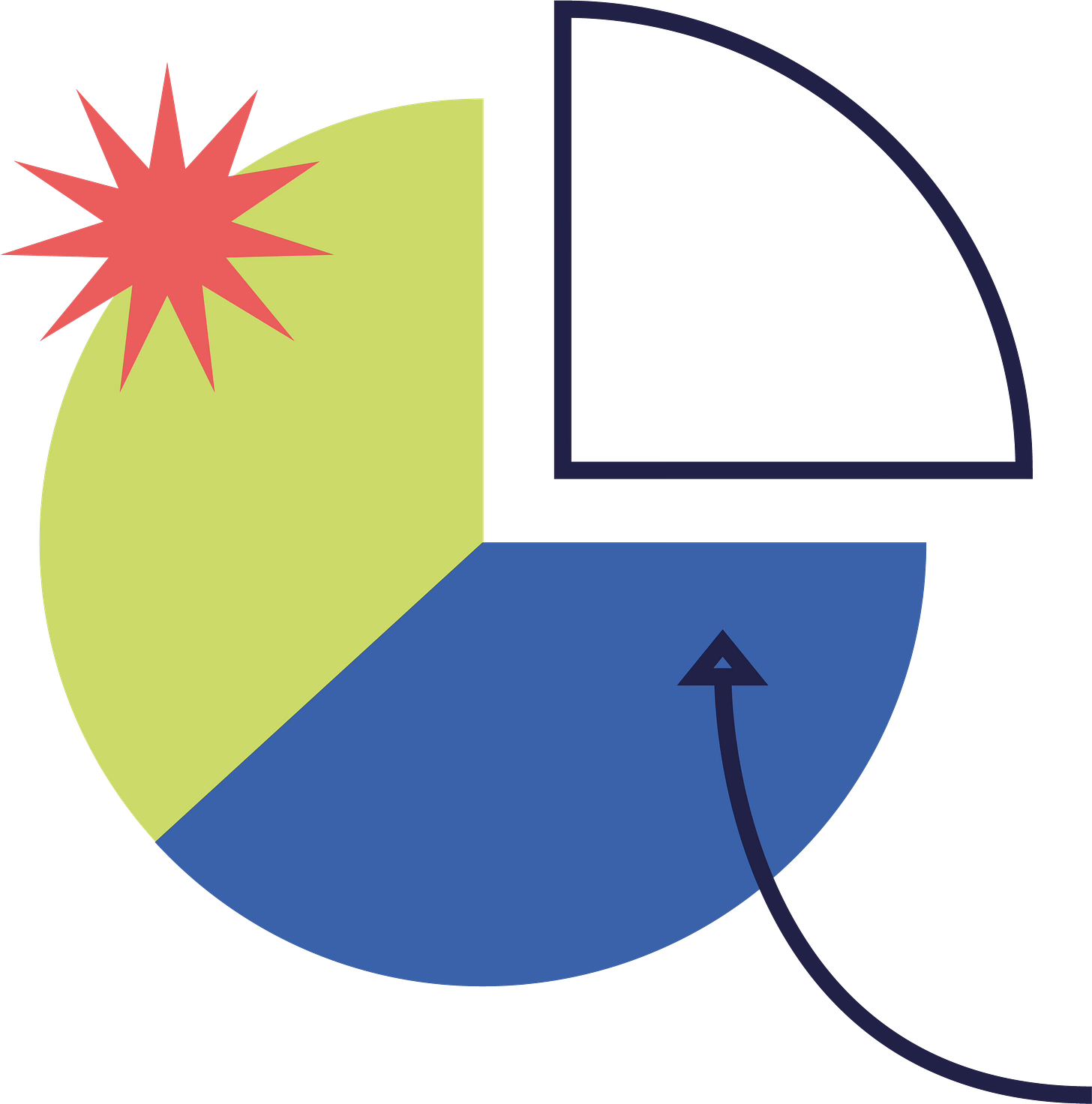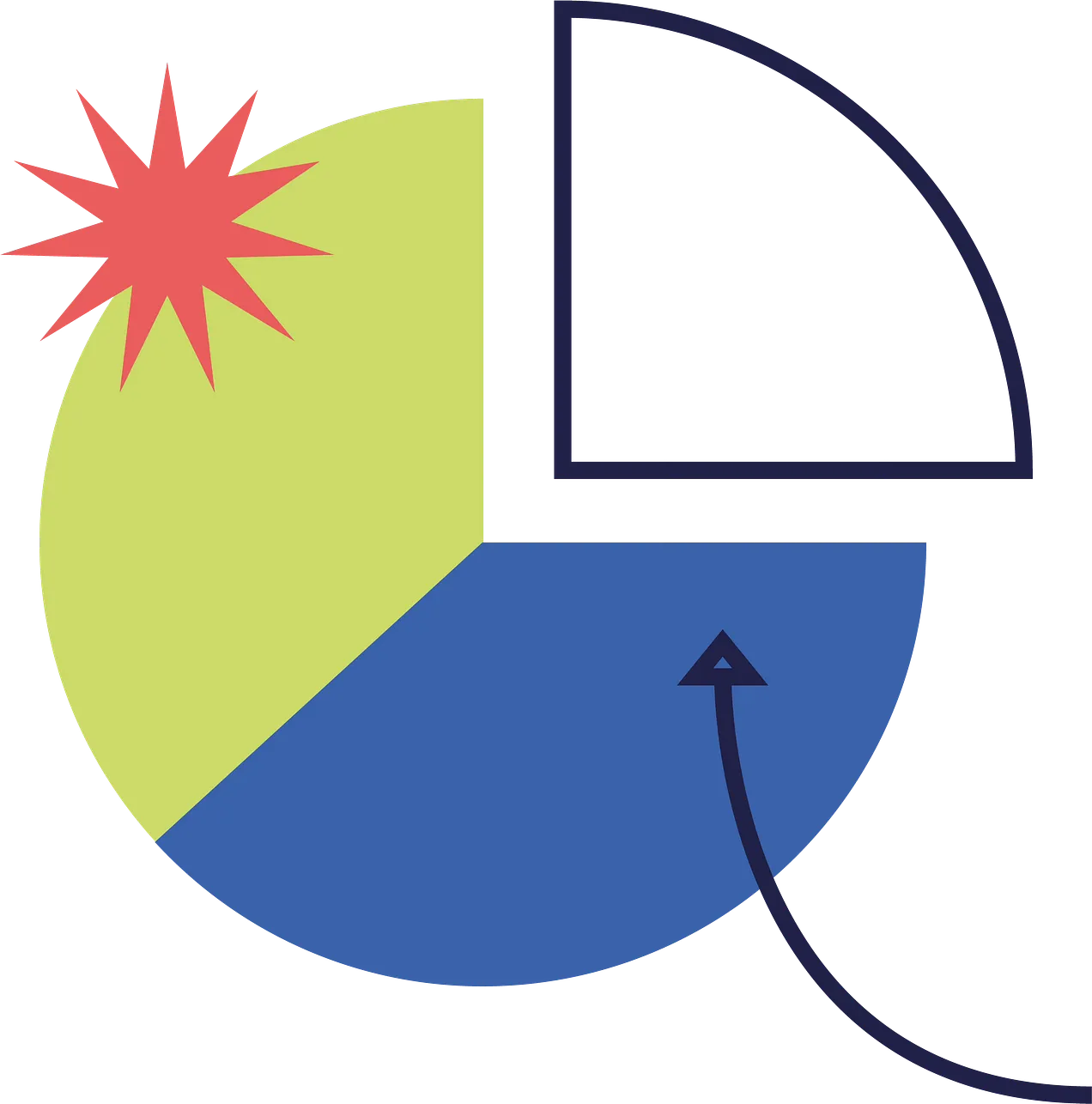I dati? Non ce li siamo inventati in Occidente
Pratiche per decolonizzare la data visualization
In questo numero: tra le dichiarazioni incredibili a cui mi/ci tocca assistere in questi mesi ci sono anche quelle che riguardano la presunta superiorità dell’Occidente in vari ambiti. Evastaizitta mi ha ricordato che vent’anni fa all’università ho studiato il concetto di etnocentrismo, e pensavo che fossimo tutti in grado di riconoscerlo, ma a quanto pare non è così. Ecco, in questa newsletter vorrei ricordare che nemmeno quella dei dati e dei grafici è una storia bianca e occidentale.
Nella sezione a pagamento: succedono cose abbastanza incredibili a chi fa rilevamento dati per Istat, l’AI può aiutarci ad analizzare i dati, c’è un data progetto sulle discriminazioni e i dati sul morbillo (sigh).
Lo spazio sponsor questa settimana è del collettivo Espulse, che ha pubblicato la prima inchiesta sulle molestie nelle scuole di giornalismo italiane. Ha da poco lanciato una raccolta fondi a cui vi invito a partecipare.
Dove ci vediamo in giro:
Online, 21 marzo: in pausa pranzo sono ospite dei Gender Lunch Seminar organizzati dall’università San Raffaele, parlo di femminismo dei dati. Si può seguire liberamente da questo link.
Online, 22 marzo: tengo una lezione sugli algoritmi nel corso di Lucy sulla strategia digitale.
Napoli, 26 marzo: intervengo in una formazione per giornalisti con WeWorld dalle 9:00 alle 13:00, presso la Sala dei Baroni al Maschio Angioino di Napoli.
🗞️ [angolo SkyTg24] A tre milioni di cittadine e cittadini italiani con disabilità è stato tolto il diritto di decidere come vivere la propria quotidianità in modo autonomo e indipendente. O meglio, è stato detto: il tuo sogno di gestire la tua vita come preferisci, come gli altri italiani senza disabilità, è rimandato al 2027. È quello che è accaduto con il rinvio della piena attuazione del decreto legislativo 62/2024 compreso nella riforma sulla disabilità avviata nel 2021, che introduceva il progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, suscitando, giustamente, diverse critiche.
Sei tra le 10789 persone che leggono la newsletter. Nell’ultima puntata abbiamo parlato di cherry picking, da maneggiare con cura.
Intanto ti ricordo che se vuoi coinvolgermi in un evento puoi scrivere a contact-columbro@elastica.eu.
Per promuovere il prodotto della tua azienda, un evento o un corso in questi spazi scrivi a newsletter@tispiegoildato.it, rispondo io oppure Roberta.
E se facessimo un passo di lato? Al di fuori dei sentieri battuti e ribattuti delle ponderazioni, delle divagazioni e delle disquisizioni, al di fuori delle strutture di bolle orbitanti intorno a un centro comune.
Olga Tokarczuk, Il tenero narratore e altri saggi (Bompiani 2024)
Decolonizzare la data visualization e la storia dei dati
Prima sono arrivate le nuove linee guida per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione del ministero dell'Istruzione che dicono
«Solo l’Occidente conosce la Storia».
Poi sabato scorso da un palco di piazza a Roma persone come Antonio Scurati e Roberto Vecchioni hanno detto che “noi”, l’Europa, non è come “gli altri”, non deporta, non uccide, non massacra i civili”, e le scrittrici Igiaba Scego a Djarah Kan hanno fatto notare l’ipocrisia di queste parole, pronunciate nella fortezza Europa che respinge i migranti o li lascia in Libia a farsi torturare.
L’antropologo Francesco Remotti parlava di etnocentrismo non solo in quanto approccio ricco di pregiudizi, ma di come si mette al centro la propria cultura, lasciando ai margini quelle delle altre società, anche nello studiare e analizzare il presente.
Quando pensiamo alla storia della data visualization, i nomi che sentiamo citare più spesso sono i soliti William Playfair, con i suoi grafici a linee e a barre, Florence Nightingale con i dati dalla guerra di Crimea e la sua rosa polare, e John Snow con la mappa del colera a Londra. L'idea diffusa è che la rappresentazione visiva dei dati sia un'invenzione occidentale, un prodotto dell'Illuminismo e della rivoluzione industriale. Ma questa narrazione è incompleta e, come molte storie della scienza e della conoscenza, fortemente euro-anglo-centrica. Se insegni design o data visualization, o se hai assistito a una lezione in materia, prova a pensare se ti è capitato di citare o vedere nelle slide esempi di grafici realizzati (prima dell’800) in paesi dove si parla una lingua diversa dall'inglese o sono rappresentati fenomeni sociali che mostrano le discriminazioni subite dai popoli dominati e colonizzati.
Un progetto che sta contribuendo a riscrivere questa narrazione è Data by Design (dataxdesign.io), una storia interattiva della visualizzazione dei dati dal 1786 al 1900 che esplora come attivisti, economisti, educatori e politici del XVIII e XIX secolo utilizzassero le visualizzazioni per produrre nuova conoscenza e plasmare il dibattito pubblico. L’obiettivo è mostrare che
la data visualization è sempre stata uno strumento di potere e che la sua storia non può essere raccontata solo attraverso lo sguardo occidentale.
Il progetto è guidato da Lauren Klein, che conosciamo per Data Feminism, in collaborazione con l'Emory Center for Digital Scholarship e Polymode.
Tra le viz analizzate dal team di ricerca ci sono le opere di William Edward Burghardt Du Bois, sociologo e attivista afroamericano, che all'Exposition Universelle di Parigi del 1900 presentò una serie di straordinari "data portraits" per raccontare la realtà sociale ed economica degli afroamericani negli Stati Uniti post-schiavismo. I suoi grafici, realizzati con forme e colori innovativi, non solo rappresentavano dati, ma raccontavano una storia, ribaltando le narrazioni razziste dominanti dell'epoca:

In Decolonizing Data Viz la studiosa Stephanie Evergreen sostiene che considerare la disciplina della visualizzazione dati come una pratica dell’Illuminismo bianco ed europeo sia un peccato di “pigrizia”:
tutto ciò che è stato prodotto in passato dalle società indigene viene semplicemente relegato nella sfera decorativa, annientando la complessità di comunità politiche e sociali molto stratificate a livello di leggi e gerarchie in realtà.
Guardando con altri occhi i vestiti tradizionali dei nativi americani, per esempio, la simbologia di ogni disegno comunicava aspetti anche quantitativi di una certa dinastia o famiglia rispetto a un altra. L’artista Apsáalooke Wendy Red Star ha annotato una foto di Peelatchiwaaxpáash per evidenziare i dati incorporati nei suoi capelli e nel suo abbigliamento cerimoniale. Queste annotazioni (uno strumento diffuso nella visualizzazione dei dati) mettono in evidenza informazioni relative alle guerre avvenute nel 1800:
La rappresentazione dei dati porta sempre con sé una visione del mondo e relazioni di potere, ricordano autori e autrici del progetto dataxdesign.io, che dedicano un intero capitolo a William Playfair, l'inventore del grafico a linee e a barre: l’inglese creava visualizzazioni pensate per un'élite economica e politica, mostrando surplus e deficit commerciali dell'Inghilterra in un'epoca in cui l'impero coloniale si espandeva attraverso il saccheggio e la schiavitù.

I suoi grafici non erano neutrali: erano strumenti per rafforzare il potere economico britannico, rendendo leggibile solo ciò che era rilevante per le classi dirigenti dell'epoca. È interessante che Klein e il suo team di ricerca distribuiscano in qualche modo le responsabilità di come usiamo e leggiamo dati e statistiche che crediamo neutrali:
il fatto che un designer possa non essere consapevole dell’argomentazione implicita nelle sue scelte progettuali non significa che questa non esista, né invalida le intuizioni che la visualizzazione è stata concepita per generare. Al contrario, essere consapevoli di questa argomentazione ci permette, in quanto osservatori, di comprendere meglio ciò che stiamo effettivamente guardando e quali inferenze possiamo trarne in modo appropriato.
Non abbiamo molte scuse, una volta diventatə consapevoli di come funzionano dati e grafici.
Questa newsletter è sostenuta da: Espulse
Da più di un anno, il collettivo Espulse porta alla luce un fenomeno sommerso: le molestie sessuali e la discriminazione di genere nel giornalismo italiano. Dopo otto mesi di lavoro, abbiamo scritto “Voi con queste gonnelline mi provocate”, la prima inchiesta sulle molestie nelle scuole di giornalismo italiane, pubblicata su IrpiMedia e ripresa da oltre 70 testate italiane e internazionali.
E il nostro lavoro ha avuto un impatto concreto: a dicembre 2024, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha approvato un nuovo Codice etico per le scuole di giornalismo.
Adesso vogliamo andare oltre. Come?
Abbiamo deciso di lanciare un crowdfunding per finanziare la nostra prossima inchiesta sulle molestie nelle redazioni italiane.
Grazie al tuo supporto potremo ampliare il nostro team legale, proteggerci dalle querele temerarie, viaggiare per raccogliere testimonianze.
Perché sostenerci?
Perché solo un giornalismo libero da molestie e discriminazioni può raccontare il mondo e le vite delle donne che lo abitano.
Perché lavoriamo con un metodo e un’etica femminista: garantiamo privacy e anonimato a chi denuncia e facciamo inchiesta con rigore e responsabilità.
Perché il nostro lavoro ha già avuto impatto, ma possiamo fare ancora di più. Con te.
Sostieni la nostra raccolta fondi qui.
I data-link della settimana
a cura di Roberta Cavaglià