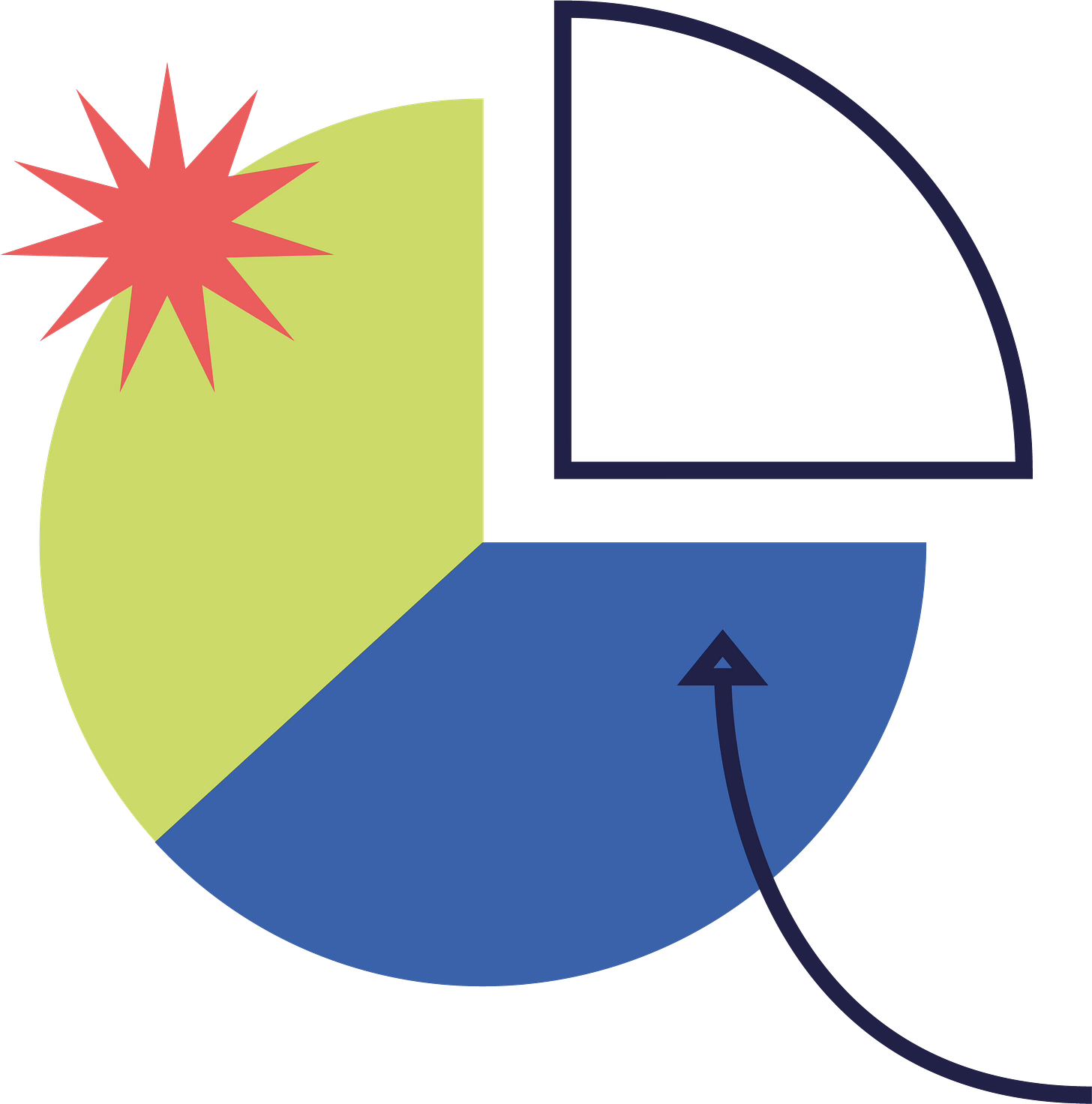La donna che conta gli scoiattoli in Italia
e molti altri animali. Oggi tornano le interviste alle data guest star.
In questo numero: cosa vuol dire svegliarsi la mattina, aprire la posta e verificare gli alert di segnalazioni di scoiattoli grigi in Italia? Oppure seguire le impronte di lepri alpine sulla neve, per lavoro? L’attualità si mette in pausa questa settimana, ma nell’intervista a Valentina La Morgia, ricercatrice Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e docente al corso di Scienze Naturali all’università di Torino, troverete anche risposte su come trattare i dati che riguardano temi di cui abbiamo parlato nelle ultime settimane.
Un annuncio:
Csv,conf,v9 è un evento pensato per chi crea, cura, usa e ama i dati: l’edizione di quest’anno si terrà a Bologna, dall’8 all’11 settembre 2025 e il tema sarà “Dati per le Comunità”. Hai tempo fino al 27 aprile per proporre il tuo intervento a questo link. Se prima vuoi dare un’occhiata alle edizioni precedenti, puoi farlo qui.
E, attenzione: la newsletter si prende una settimana di pausa e torna il 30 aprile!
Dove ci vediamo in giro:
17 aprile, online: dialogo con Simone Ferrari, presidente del MENSA Italia.
3-4 maggio, a Foligno: intervengo al convegno del Gruppo di Terapia Manuale dove il tema è “Umanizzare i dati evolve la fisioterapia muscoloscheletrica”. Iscrizioni aperte.
11 maggio, Roma: alla prima edizione del festival Semi di Reti presso Villetta Social LAB, nel quartiere Garbatella, un incontro su lavoro, gender gap e discriminazioni. Alle 17.
🗞️ [angolo SkyTg24] L’8 dicembre 2024, M., 15 anni, ha lasciato un esplosivo vicino a una stazione di polizia a Kharkiv, nell’Ucraina orientale. In un video di sorveglianza, si vedono due persone davanti all’ingresso e due agenti che escono proprio un attimo prima dell’esplosione. “Un’amica mi ha mostrato un gruppo su Telegram con offerte di lavoro da 1.000 a 3.000 dollari”, ha raccontato M. all’Istitute for war and peace reporting (IWPR). “Scrivevano che si trattava di incendi. Ho rifiutato e allora mi hanno proposto di aiutare a incastrare un poliziotto corrotto”. Seguendo le istruzioni del suo contatto, ha piazzato un telefono con videocamera vicino alla stazione di polizia, poi ha preso un pacco e lo ha lasciato in un cestino dell’immondizia accanto all’edificio.
“Ero convinta di non aver fatto nulla di grave. Pensavo ci fosse una microspia nel pacco. Non sapevo che fosse una bomba”.
Per Sky ho scritto dell’inchiesta di Texty.org e dell’IWRP, con dati confermati dall’ONU, sul crescente coinvolgimento di minorenni in attentati terroristici in Ucraina da parte della Russia. Entrano “nel giro” attirati da soldi facili, e poi non riescono più a uscirne, incastrati da minacce ritorsioni. La metà di loro sono ragazze, come M..
Sei tra le 11462 persone che leggono la newsletter. Nell’ultima puntata ti abbiamo raccontato che finalmente il ministero dell’interno ha pubblicato il report trimestrale sugli omicidi volontari.
Vuoi contribuire alla realizzazione di questa newsletter con un abbonamento a pagamento? Il tuo sostegno copre i costi dei contributi esterni che rendono sempre più ricchi questi spazi! E la sezione curata da Roberta qui sotto è ricchissima di link interessanti oggi.
Intanto ti ricordo che se vuoi coinvolgermi in un evento puoi scrivere a contact-columbro@elastica.eu.
Per promuovere il prodotto della tua azienda, un evento o un corso in questi spazi scrivi a newsletter@tispiegoildato.it, rispondo io oppure Roberta.
Tutti noi che viviamo immersi nei dati dobbiamo imparare a immaginare meglio i futuri possibili. Non solo quelli tecno-utopici, in cui il nostro lavoro contribuisce al bene comune, ma anche quelli meno promettenti, in cui le nostre azioni espongono persone e ambienti a rischi concreti. È fondamentale capire che raccogliere dati significa, in modo reale e tangibile, entrare in contatto con chi quei dati li incarna.
Jer Thorp, Living in Data (Macmillan Publishers 2021)
3(+1) domande sui dati a... Valentina La Morgia
Ho incontrato Valentina La Morgia alla presentazione del mio libro “Quando i dati discriminano” all’Istituto Agnelli di Torino, lo scorso febbraio. “Lei di lavoro conta gli scoiattoli”, mi dice uno degli organizzatori. Quelle due o tre parole scambiate con Valentina prima dell’incontro mi fanno capire che devo segnarmi il suo contatto, tornare su quello che mi racconta, perché tutto quello che insegno e predico sui dati ancora una volta diventa vivo, evidente, quando qualcuno descrive passo dopo passo come funziona la produzione di dati e statistiche che cambiano la nostra vita e i nostri ambienti. E quindi, eccola, con molta gratitudine a lei e a ISPRA per la possibilità di ospitare questa intervista.
1. Presentati, raccontando che lavoro fai e com'è la tua "giornata tipo".
La domanda "che lavoro fai?" mi mette sempre in crisi. Sono ecologa e mi occupo di gestione e conservazione delle specie animali, in particolare dei mammiferi. Ma spiegare in cosa consista esattamente questo lavoro non è semplice: non è una professione comune e le parole che lo descrivono non evocano immagini immediate.
Dopo una laurea in Scienze Naturali (2001) e un dottorato in Biologia Evoluzionistica e Conservazione della Biodiversità (2007) all’Università di Torino, ho lavorato per circa dieci anni in ambito accademico. Oggi, all’ISPRA, applico le conoscenze scientifiche per affrontare i conflitti tra attività umane e fauna, sviluppando strategie di conservazione.
Il mio lavoro spazia dallo studio dell'impatto dei ghiri nei noccioleti alla gestione di specie aliene invasive come lo scoiattolo grigio, fino alla conservazione di predatori iconici come il lupo e l’orso. Analizziamo anche gli effetti dei cambiamenti climatici su specie alpine vulnerabili, come la lepre variabile, il mio “bianconiglio” preferito.

Ci sono quindi naturalisti e biologi che trovano la propria strada lavorando principalmente in laboratorio. Il mio lavoro invece consiste nel raccogliere i dati in ambienti naturali.
Ma non è solo ricerca sul campo con zaino e scarponi: la maggior parte del tempo la passo davanti al computer, analizzando dati e sviluppando modelli predittivi per supportare le decisioni gestionali. È un lavoro vario, complesso e spesso poco conosciuto, ma (spero) importante per la tutela della biodiversità.
2. Una domanda che faccio a tutte le ospiti: cosa sono i dati per te?
Alcuni miei colleghi mi prendono in giro per il modo in cui parlo dei dati, soprattutto con quelli stranieri, quando parlo in inglese. Dicono che traspare una sorta di rispetto – o addirittura venerazione – per i dati. Forse hanno ragione, e c’è un motivo preciso: raccoglierli è sempre una sfida. Servono risorse economiche (che non abbondano mai), tempo (la natura ha i suoi ritmi e bisogna saper aspettare), competenze tecniche e statistiche per farlo nel modo giusto, e persino un po’ di fortuna. Perché in ambiente naturale il controllo delle condizioni è sempre parziale. Avere tra le mani un buon dataset significa aver fatto pianificazione, fatica – e a volte, in montagna, anche tanta salita – per porci la domanda giusta. Se quella domanda non era ben formulata o se il metodo di raccolta non era corretto, tutta quella fatica rischia di essere sprecata.
Per questo, quando finalmente abbiamo dei dati su cui lavorare, credo sia giusto portar loro il dovuto rispetto.
Ma cosa rappresenta davvero un dataset costruito con tanta attenzione? In un certo senso, è il nostro modo di leggere la realtà ('il processo di stato'), un riflesso dei fenomeni naturali che cerchiamo di comprendere. Vorremmo che i dati fossero una rappresentazione fedele di ciò che accade, ma la verità è che quello che ci raccontano dipende dalla domanda che ci siamo posti, da come li abbiamo raccolti ('il processo di osservazione') e da come li interpretiamo.
Un giorno, uno studente mi ha colpita con una riflessione: i dati sono come le ombre nella caverna di Platone. Non vediamo mai la realtà in modo diretto, ma solo attraverso la luce che abbiamo a disposizione – e quella luce è il nostro metodo di raccolta dati. La posizione della “torcia” (cioè il modo in cui formuliamo le nostre domande e strutturiamo la ricerca) determina ciò che possiamo vedere e capire. Per questo, integrare dati da fonti diverse e mantenere un approccio critico è essenziale: solo così possiamo avvicinarci a una visione più completa del mondo naturale.

3. Qual è una criticità del tuo ambito di lavoro dove l’uso, la citazione o la cattiva interpretazione dei dati e delle statistiche può fare dei danni?
Credo di avere davvero tantissimi esempi, e anzi di non riuscire a identificare un caso in cui questo non sia vero. Il fatto stesso che i dati che produciamo siano raccolti espressamente con la finalità di informare delle scelte di gestione fa sì che essi siano sempre interpretati, anche da non addetti ai lavori, e che questa interpretazione abbia delle ricadute più o meno immediate sulla conservazione delle specie e sui rapporti che abbiamo con loro.
Ad esempio, ogni volta che ci occupiamo di analisi della dinamica delle popolazioni (cioè quando studiamo come il numero di animali cambia nel corso del tempo e dello spazio), c'è il rischio di interpretare i trend osservati in maniera più o meno ottimistica o allarmistica. Questo può portare a decisioni di gestione che, basandosi su una lettura distorta dei dati, hanno conseguenze indesiderate. Un caso emblematico e molto dibattuto è stato quello dei modelli sviluppati dal mio Istituto per la gestione dell'orso in Trentino. In quest’area, il grande plantigrado convive con un ambiente fortemente antropizzato, dove i contatti con l’uomo sono frequenti e possono avere pesanti conseguenze, che tutti vorremmo evitare. Tuttavia, l’orso è una specie di interesse conservazionistico, e l’Italia ha obblighi internazionali per la sua tutela.
Fornire modelli sui trend delle popolazioni significa offrire una base di informazioni ai decisori politici, ma la loro interpretazione non è sempre neutra. Ad esempio, un incremento nel numero stimato di orsi può essere riportato nei media con titoli allarmistici, suggerendo una crescita esponenziale e incontrollata della popolazione. Questo può alimentare la percezione pubblica di una “emergenza orso”, influenzando le richieste di interventi drastici, come abbattimenti o limitazioni ai progetti di reintroduzione. Al contrario, lo stesso dato può essere presentato mettendo in evidenza la distribuzione spaziale della popolazione e le sfide nella gestione della convivenza, offrendo una prospettiva differente.
Un altro esempio di come i dati possano essere presentati, interpretati e usati è legato alla gestione delle specie aliene invasive, un campo nel quale le posizioni sono spesso estremamente polarizzate. C'è chi propende per una visione a livello di individuo, e per tutelarne il benessere è contrario alla rimozione di animali invasivi. C'è invece chi guarda di più al funzionamento del sistema naturale nel suo complesso e supporta i programmi di rimozione. Nei progetti su queste specie spesso si lavora anche in contesti urbani, dove è fondamentale spiegare alla popolazione il perché di interventi di rimozione. La presentazione dei risultati relativi a queste attività è un elemento chiave: semplici differenze nella rappresentazione grafica possono guidare il pubblico in una direzione o nell'altra, e spesso gli stessi dati possono essere interpretati, rappresentati e usati, da portatori di interesse diversi, a supporto di posizioni diverse.
La presentazione e l’interpretazione dei dati possono quindi influenzare le decisioni di gestione e l’opinione pubblica. Spesso, non è solo una questione di avere dati affidabili, ma di come vengono comunicati e utilizzati. Anche scegliere di non intervenire è una scelta gestionale con conseguenze reali. Per questo, è fondamentale che i dati vengano letti e diffusi con consapevolezza, per evitare distorsioni o semplificazioni eccessive.
4. Cosa consigli a chi vuole fare un lavoro che riguarda i dati nel tuo ambito?
Pur lavorando all'ISPRA da molti anni, continuo a collaborare con l'università, dove insegno le basi per la raccolta e l'elaborazione dei dati ecologici e l'applicazione di metodi quantitativi per la gestione della fauna. La maggior parte degli studenti che intraprende studi biologici, naturalistici o veterinari è affascinata dagli ambienti naturali e, all'inizio del proprio percorso, spesso ha un’idea un po’ diversa di cosa significhi davvero lavorare in questo campo. È successo anche a me, ma con il tempo ho cambiato prospettiva. Nei miei insegnamenti cerco di trasmettere la passione per l’analisi dei dati, perché c’è qualcosa di entusiasmante nel riuscire a capire cosa si cela dietro una serie di valori raccolti sul campo. Il mio consiglio è di non vedere l’informatica e la statistica come ostacoli da superare, ma come preziosi alleati.
A chi invece proviene da altre discipline e vuole applicare le proprie competenze analitiche alle scienze naturali, consiglio di dialogare il più possibile con biologi e naturalisti. Esiste una sorta di leggenda secondo cui, per i matematici, le popolazioni sarebbero “tonde”, un modo ironico per dire che spesso i modelli utilizzati risultano troppo astratti e semplificano eccessivamente la distribuzione degli animali. Sfatiamola! O almeno, cerchiamo un equilibrio: tra eccessivo realismo e astrazione esiste sicuramente una via intermedia, e soltanto unendo gli approcci possiamo trarne dei vantaggi. Le collaborazioni che ho avuto con matematici e statistici sono state tra le esperienze più formative della mia carriera: all’inizio sembra di parlare lingue diverse, ma il confronto continuo, il networking e il lavoro di squadra fanno davvero la differenza.
Valentina La Murgia è ecologa all'Ispra, l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Nel sito di Ispra tra l'altro c'è una sezione dati molto ricca, andrei a farci un giro fossi in voi.I data-link della settimana
a cura di Roberta Cavaglià